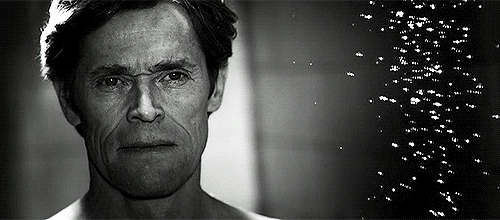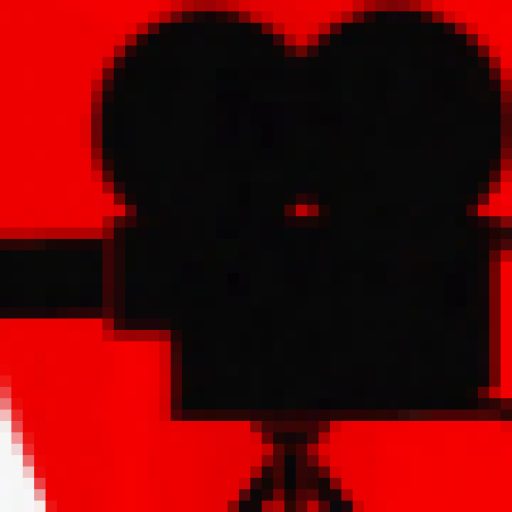L’altro ascolto …
a cura di Roberto Bernabò

A pensarci bene, il cinema documentarista, tema a me assai caro, condivide la forma dell’intervista con il reportage e con le inchieste televisive.
Ma la dovizia di interviste filmate, al cinema ed in televisione, l’inflazione e la ripetizione della formula, non significano soltanto il facile ricorso ad una figura comoda, banale, senza prospettive.
Convocare qualcuno su una scena per farlo parlare ed eventualmente ascoltarlo, per fare della sua parola qualcosa che non sia inutile, non è mai stato, non può essere un gesto anodino. Porsi di fronte all’altro, stabilire con lui una relazione particolare che passa attraverso una macchina ha un senso, comporta una responsabilità, anche se è del tutto banale. Due soggetti s’impegnano – in rapporto a questa macchina – in una sorta di duello, un faccia a faccia, una relazione, una congiunzione più o meno tesa dal desiderio, più o meno marcata dalla paura e dalla violenza. E se questi due soggetti non s’impegnano uno nei confronti dell’altro, la macchina prende atto, crudelamente, dell’assenza di questa relazione, della nullità di questo incontro. Non si filma impunemente – ed il corpo dell’altro, la sua parola, la sua presenza, meno ancora.
Quali che siano, quindi, la varietà e l’automaticità dei dispositivi della messa in scena (intendo che la maggior parte delle volte si applica una formula già pronta, senza pensarla), la pratica dell’intervista pone una delle questioni fondamentali del Cinema: “la questione dell’altro“.
§§§
1. Qual è lo statuto dell’altro filmato?
Cosa aspettarsi, cosa desiderare da lui, cosa domandargli? Come ascoltare la sua domanda, cosa ne é della sua aspettativa di messa in scena, del suo desiderio di Cinema?
Ma anche (è sempre la questione dell’altro filmato): che fare dell’alterità in un sistema di scrittura che induce all’omologazione?
Che fare dell’altro in un cinema contraddistinto dalla conciliazione?
Che fare dell’altro, quale posizione dargli che non sia quella di una riduzione né di una stigmatizzazione, all’interno stesso di una cultura del consenso politico (con chi, contro chi?)

E nel momento in cui il dispositivo di base della scrittura cinematografica (in e off, metonimia e metafora) induce un sistema di conciliazione, una logica del compromesso.
La situazione verbale più frequente nei documentari (compresi i miei piccoli corti), è il rivolgersi del narratore a – non si sa bene chi – colui che è alla macchina da presa, al fianco della camera, dietro la camera, e che pone domande, domande a volte mute e spesso eliminate al missaggio ed al montaggio.
La messa fuori campo del destinatario non è, però attenzione, la sua messa fuori scena.
Egli resta di fatto colui che costituisce l’innesco del racconto (che domanda, che ascolta). Tuttavia, il suo mettersi da parte arriva a trasformare la realtà del dialogo in un monologo immaginario. Si stabilisce una confusione tra questo destinatario divenuto assente – l’uomo che sta dietro la camera, che può a sua volta sdoppiarsi in operatore e regista, o anche ridividersi in un intervistatore specializzato – la stessa camera (fuori campo ma non fuori scena), e terzo vertice del triangolo, lo spettatore, che si suppone sia dall’altro capo della catena, e di cui i due precedenti angoli sono in qualche modo rappresentanti per anticipazione. Dal momento che occorre che una parola sia ascoltata per essere profferita, l’insieme di questo ascolto fuori-campo-ma-non-fuori-scena, reale e potenziale, gioca un ruolo strutturante nel racconto filmato e determina, in gran parte, la messa in scena, tramite il narratore stesso, del percorso e della destinazione del suo racconto: sguardi, mimica, movimenti, ecc.
Una tale confusione sembrerebbe stigmatizzabile, se non avesse come scopo, appunto, quello di disturbare l’assegnazione di una ed una sola posizione al destinatario ultimo del racconto: lo spettatore.

Siccome il narratore, di fatto, non sa propriamente a chi s’indirizza, alla camera, all’operatore, al fonico (quando c’è), al regista, eventualmente all’intervistatore (o a tutte queste figure unite in un unico, nella ripresa digitale del videomaker), e sicuramente allo spettatore, il solo, nel caso, ad essere effettivamente assente dalla scena, ne risulta un turbamento dello sguardo che si ripercuote dal narratore all’ascolto dello spettatore.
Quando il locutore non sa più bene a chi e per chi enuncia, non può fare altro che indirizzarsi a se stesso, che diventare il proprio stesso ascoltatore. Raddoppio che mette in campo un monologo ed, al tempo stesso, lo lavora e lo spezza di nuovo, con un dialogo impossibile. Il soggetto della parola filmata, privato del riferimento rassicurante di un ascoltatore assegnato a residenza fissa, si trova nell’obbligo d’inventare sul campo il dispositivo d’ascolto che permetterà la sua parola.
E’ così che si forma, tra altre condizioni di crisi, la necessità di un’auto regia del personaggio.
Quello che, forse, è specifico della pratica documentarista, è che essa suppone un non-controllo di ciò che la costruisce: la relazione con l’altro.
Tale posizione fragile sembra andare contro la nozione di regia.
Eppure.
Eppure è proprio questa contraddizione che fonda questo tipo di pratica.
Abbordare la questione di questo altro punto di vista, della paura che ne abbiamo, è proprio significare, a ben guardare, il suo contrario: il desiderio (degli uni e dell’altro).
C’è un movimento positivo nel documentario, cioè che noi amiamo, l’altro che filmiamo, e che, quindi, tutto va bene.
Proviamo a partire dall’idea contraria, gli altri sono difficili da comprendere, dunque ho bisogno di filmarli. (Ho iniziato a comprendere le cose da quando ho iniziato a riprenderle – Wim Wenders).
§§§
2. Come si procede alla scelta della persona da filmare?

E’ in questa scelta che interviene la paura. La paura, ma anche il desiderio, quindi ambivalenza. Paura di tradire, d’ingannare chi si sta filmando, ma amche paura del proprio desiderio.
C’è si la paura, ma c’è anche il desiderio di essere travolto. Di essere smentito dai fatti. Più il film è preparato, più si è travolti, più lo shock è potente.
Come ridurre la paura, ritualizzare l’altro in modo da sostenerlo?
Caos della pulsione / ritualizzazione dell’atto. desiderio di mettere in scena, di limitare, di mettere in forma, con la speranza che l’altro potrà dare il suo contributo.
Sorridere ad una macchina: una forma di delirio molto particolare.
Una macchina non è un soggetto. Ma senza macchina non c’è film. L’intensità sovradeterminata della macchina. Più la macchina è forte, meno si dimetica il dispositivo, più la relazione si obbliga ad essere intensa.
Nel desiderio dell’altro, ci sarebbe il desiderio, voglio proprio svelarvelo in conclusione di questa lunga riflessione, di non essere presi per poca cosa.
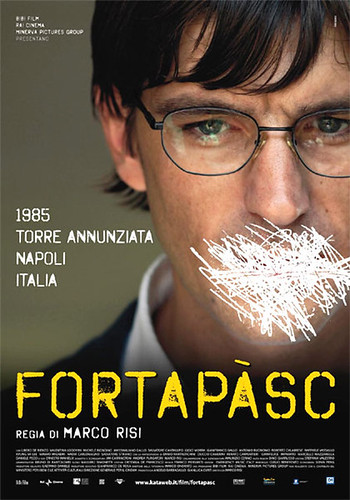






 = Capolavoro
= Capolavoro = Eccellente
= Eccellente = Ottimo
= Ottimo  = Buono
= Buono  = Discreto
= Discreto  = Insufficiente
= Insufficiente = Mediocre
= Mediocre = Brutto
= Brutto = Punizione
= Punizione  = Incubo
= Incubo