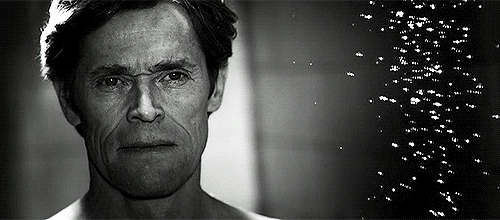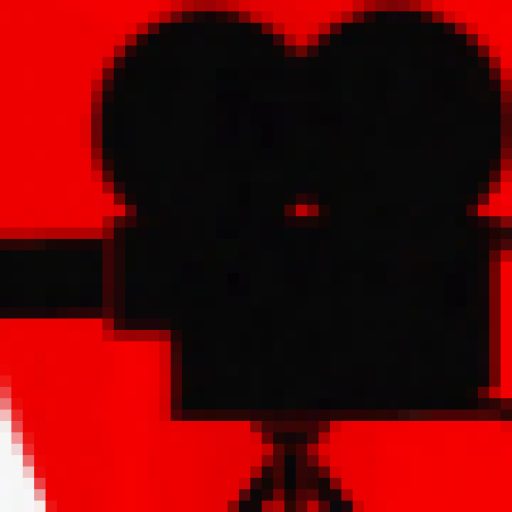2009 – Francia
analisi di eventi, esistenti e linguaggio audiovisivo
Amore clandestino, coraggio e disperazione sulla Manica – a cura di Roberto Bernabò
Welcome
titolo originale: Welcome
nazione: Francia
anno: 2009
regia: Philippe Lioret
genere: Drammatico
durata: 110 min.
distribuzione: Teodora Film
titolo originale: Welcome
cast: Vincent Lindon (Simon) • Firat Ayverdi (Bilal) • Audrey Dana (Marion) • Derya Ayverdi (Mina) • Thierry Godard (Bruno) • O. Rabourdin (tenente Caratini) • Y. Renier (Alain) e con Murat Subasi, Firat Celik, Selim Akgul, Yannick Renier
sceneggiatura: O. Adam • E. Courcol • P. Lioret
montaggio: A. Sedlackova
![]()
Trama: Il giovane curdo Bilal ha attraversato l’Europa da clandestino nella speranza di raggiungere la sua ragazza, da poco emigrata in Inghilterra. Arrivato nel nord della Francia, capisce che la sua unica possibilità è tentare di attraversare la Manica a nuoto. Alla piscina comunale, dove va per allenarsi, finisce per diventare amico di Simon, un istruttore in piena crisi con la moglie, che decide di aiutarlo in questa impresa all’apparenza irrealizzabile.
Benvenuto! Se ti ho conosciuto da poche ore
e mi ricordo anche a fatica il tuo nome.
Benvenuto! Se sei arrivato tra mille casini e tempeste
in questa terra che ti può ospitare.
Benvenuto! Se ancora non ti conosco
ma ho voglia di darti una pacca sulle spalle.
Benvenuto! E Grazie! Se mi farai riconoscere Gesù
che mi cerca ancora attraverso di te!
§§§
1. Introduzione – “E invece”

Alle volte sono misteriose le cosmogonie che si muovono intorno alle visioni in sala di una pellicola.
Avevo letto di questo film perché, da qualche anno ormai, scrivo ogni settimana un post sui film in uscita, nell’altro mio blog.
Avevo capito che il regista Philippe Lioret ha ricevuto diversi awards per questa sua opera, ed in particolare ben due all’ultimo Berlino Film Festival e precisamente: il Label Europa Cinemas – Tied with Nord (2009) ed il Prize of the Ecumenical Jury – Panorama. E la cosa mi era sembrata anomala. Un film francese premiato a Berlino, mi ero detto.
Poi, questa mattina, una mail pervenuta all’account collegato a questo blog, mi chiedeva di un altro film: “Storie di pioggia”, della regista argentina Isabel Achaval. Un documentario autobiografico, che parla della difficoltà di questa regista di lasciare l’Argentina per andare a vivere in Belgio. Una pellicola, temo, sconosciuta ai più. Uscita in Italia solo a Roma, presso la sala di proiezione di un’Associazione Culturale che si chiama Filmstudio – che si trova in via degli Orti D’Alibert 1/c.
Curioso, mi sono detto, in due soli giorni la mia vita viene attraversata da un tema che forse molti di voi credono di conoscere.
Non è così?
Vediamo, oramai da troppi anni, immagini di barconi che trasportano abusivamente immigrati, che giungono in Italia in condizioni a dir poco pietose.
Sappiamo che esistono strutture chiamate Centri di Accoglienza, che non sempre sono dei luoghi così ospitali.
E via discorrendo.
Ma sono immagini che passano insieme ad altre notizie. La nostra coscienza narcotizzata neanche le vede e le ascolta più.
E invece.
E invece noi non conosciamo, ma neanche lontanamente, i problemi, le angherie, i pericoli, che persone di tutte le età, sono costrette ad affrontare, per ridursi a fare un ultimo tratto di un disperato viaggio, che è solo la punta di un iceberg, di quella che è l’intera odissea, individuale, che ciascuno di loro è stato costretto a vivere per giungere ad un passo, spesso solo dalla morte, o, nel migliore dei casi, di una vita di stenti e di fame, con in più, ormai sempre più frequentemente ahimé, la diffidenza, se non addirittura l’odio delle popolazioni accoglienti.
Perché, mi chiedo e vi chiedo, noi non conosciamo?
La questione, come amo spesso dire, pone, in verità, più interrogativi che risposte.
Ma, immagino, e soprattutto mi auguro, che l’impegno di registi come Philippe Lioret, possano, quantomeno in parte, colmare questi vuoti, queste vere e proprie voragini, queste distanze siderali che dividono quello che noi presumiamo di sapere, dalla Verità.
E che cosa sia la Verità, al cinema, è questione davvero assai complessa, e persino perniciosa arrivo a dire.
Senza considerare quella inerente il suo rapporto con il cinema (Verità vs. Cinema), questione sulla quale si sono sono interrogate menti assai più colte della mia, una su tutte quella di Pier Paolo Pasolini. Che non so quanto non abbia senso, in effetti, citare in questo contesto, peraltro, vista la sua vicinanza alla causa dei poveri e dei più deboli, che finiscono, però, sempre, per esprimere i valori più autentici ed importanti della vita.
Mi smarcherò però, subito, da queste insidie, e mi limiterò a dire che questo film probabilmente, pur essendo scaturigine di una sceneggiatura di finzione, è sicuramente anche, e direi soprattutto, il risultato di un’osservazione e di una documentazione rigorosa, puntigliosa ed attentissima, verso quello che questo fenomeno (l’immigrazione clandestina) è, in questo momento, in Francia, una terra, fino all’elezione di Nicolas Sarkozy, sicuramente assai sensibile ed aperta al tema.
Il film nasce, infatti, come conseguenza della forte polemica scaturita dopo la promulgazione in Francia della legge sull’immigrazione voluta proprio dal presidente francese, il cui articolo L622/1 stabilisce che tutti i cittadini francesi che prestino il proprio aiuto a dei clandestini, vengano puniti con cinque anni di reclusione.
2. La zona d’ombra
Tornando al tema della nostra carente conoscenza, ed al potere divinatorio che da sempre attribuisco al cinema documentarista, mi piace toccare un concetto, mai da me espresso con tanta chiarezza, ma, al tempo stesso, a me assai caro, se è vero che l’ho già sfiorato in altri post.
Quello del Cinema inteso come una “macchina per ridurre l’alterità“, senza eliminarla e per non eliminarla.
Una macchina per fabbricare il vicino con il lontano, l’omogeneo con l’eterogeneo.
Il “tutti insieme” con il “ciascuno per sé“.
Come se il sortilegio cinematografico avesse ereditato, dalle antiche arti della magia, la funzione ed il compito di propiziare ed addomesticare l’ignoto.
Ciò che sta “fuori“: fuori campo, fuori scena, fuori dai riflettori, fuori dall’informazione accurata, fuori dal discorso, fuori lingua persino.
Come nel caso di un diciassettenne curdo che dalla Francia vuole approdare in Inghilterra, varcando la Manica a nuoto, solo per incontrare nuovamente la ragazza che ama.
Filmare il nemico (sotto le più svariate accezioni del termine), filmare l’estraneo, equivale a farlo entrare nel cerchio.
Se l’operazione cinematografica consiste proprio nel risvegliare, mobilitare e rendere più intenso lo sguardo, e l’ascolto in gioco nel mondo di noi spettatori, solo apparentemente dormienti ed indolenti (quante lacrime piango nelle visioni dei film), ecco che, allora, quegli altri che arrivano, che sopraggiungono, quegli altri che spuntano al di là dei nostri orizzonti, ed al di là dell’orizzonte stesso delle nostre parole, potremo dire che il loro fine ultimo (nonché quello del cinema) sia quello di rimetterci a confronto con questo ritorno di sguardo e di ascolto, ed, attraverso di questo tramite, aprirci finalmente gli occhi, fornirci quella guida necessaria, mai oggi come lo è stato già in passato, per squarciare con una luce di nuova consapevolezza e di coscienza, simile ad una rivelazione, quella “zona d’ombra e di oblio” nella quale vivevamo, inconsapevolmente, prima di entrare in sala.
E come la magia nera si propone d’intervenire sull’anima o sul corpo dell’altro, così la tecno-magia cinematografica si attiva per mettere il corpo dell’altro a disposizione dello spettatore. Giocare con la figura umana come il “realismo ontologico” che la rappresenta.
Immagini di corpi che diventano corpi di immagini. E’ questo il senso rivelatorio del cinema di registi che come Philippe Lioret utilizzano due filtri (gli occhi ed il cuore).
3. Gli occhi, il cuore ed il mito della sopravvivenza
Non avevo mai riflettuto, quantomeno non abbastanza, sul fatto che la macchina da presa, vera protagonista di questo blog, viene spesso paragonata ad uno strumento che si sostituisce all’occhio, e che se azionata da mani sapienti, ci può fare assistere ad una storia, o, come nel caso del cinema documentarista, ci aiuta, appunto, a risvegliare un senso nuovo, di una realtà vecchia solo in parte fino a quel momento conosciuta.
Ma non si riflette mai abbastanza sul fatto che l’occhio è solo la terminazione nervosa di un apparato assai più complesso.
Il regista-uomo-dietro-la-macchina-da-presa, a seconda del tipo di storia che intende raccontare, può fare leva su tutto quello che di umano, e di divino, visto che abbiamo in parte svelato questo tremendo potere rivelatorio che hanno le immagini nel loro rapporto con la Verità, o magari anche solo con la realtà (altrimenti un certo Gesù non avrebbe mai detto a Tommaso “Beati coloro che crederanno e non vedranno“).
Nel caso di Philippe Lioret, personalmente, ritengo che questo regista guardi agli esistenti di questo film con gli occhi, ma soprattutto con il cuore.
Nessuno sguardo della sua ripresa è privo di questo elemento.
La denuncia è si pesante.
Ed è vero, non c’è speranza per l’immigrato clandestino, sembra quasi che manchi del tutto la Pietas nel racconto.
Ma è proprio così?
Non è forse Simon un miracolato dall’incontro con Bilal.
E se è vero che è lui che tenta di salvare Bilal, non è forse Bilal, con il suo atto di coraggio supremo, e con la sua purezza di ragazzo, a salvare Simon?
E per quello che riguarda lo spettatore, non è forse in questa inclusione dell’altro nel nostro cerchio, il vero messaggio verso l’alto del film?
Non potremo mai più continuare a lasciare l’altro un clandestino, dopo la visione di questa pellicola. Reo per forza, condannto e ricercato anche se ama e se sfida la sorte con un coraggio che definire epico è riduttivo.
Noi sappiano, adesso, che non abbiamo ancora la soluzione.
Ma sappiamo anche, con drammatica evidenza, quali sono gli errori che stiamo commettendo, per il nostro cinismo, per la nostra vigliaccheria, per il nostro non volere aprire gli occhi, ed il cuore, che la macchina da presa di “Welcome“, invece, ci spalanca, senza alcuna possibilità di uscire dalla sala dove abbiamo appena assistitot alla proiezione di questo film, uguali a come quando vi eravamo entrati.
Un film così equivale, in una sola parola, ad una rinascita.
Che è in fondo, a pensarci bene, la vera funzione ultima del cinema.
Fare rinascere gli esistenti, e fare rinascere gli spettatori.
Un uomo muore ma nello stesso tempo sopravvive nel film. Anche quando l’uomo vero, ovverosia, l’attore, morirà per davvero. Non solo nella rappresentazione cinematografica.
Ed è questa sua sopravvivenza, anche da morto, che rende l’utopia del cinema l’unica utopia ancora praticabile, che ci aiuta un po’ a guarire, ed a capire un mondo sempre, invece, meno comprensibile, senza questi spazi altri di riflessione visiva, emotiva e drammaturgica.
Alla prossima.
Annotazioni a margine (certo dovrei parlarvi …)
Certo dovrei parlarvi delle rese attoriali, tutte di notevole spessore, e di quella di Vincent Lindon in particolare, un attore sempre molto apprezzato da queste parti, davvero intensa e commovente.
Certo dovrei parlarvi del fatto che credo, anche, che una visione in lingua originale di questa pellicola sia davvero da consigliare.
E certo dovrei parlarvi della programmazione artistica di piccolissimi multisala come il cinema Grenwich di Testaccio a Roma, che davvero non sbagliano mai un film …














 = Capolavoro
= Capolavoro = Eccellente
= Eccellente = Ottimo
= Ottimo  = Buono
= Buono  = Discreto
= Discreto  = Insufficiente
= Insufficiente = Mediocre
= Mediocre = Brutto
= Brutto = Punizione
= Punizione  = Incubo
= Incubo