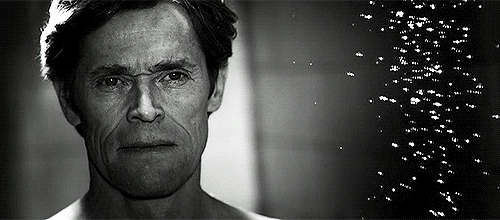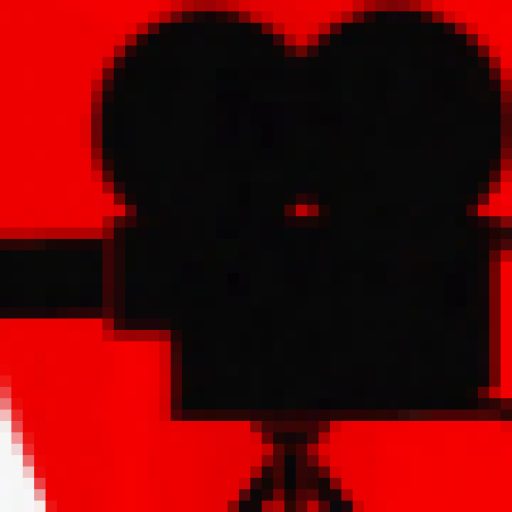analisi di eventi, esistenti e linguaggio audiovisivo
Israele | 2012

Libertà e coercizione a Tel Aviv – a cura di Roberto Bernabò

La sposa promessa
Regia: Rama Burshtein
Titolo originale: Lemale Et Ha’Chalal
Titolo internazionale: Fill the void
Anno: 2012
Nazione: Israele
Distribuzione: Lucky Red
Durata: 90 min
Data uscita in Italia: 15 novembre 2012
Genere: drammatico
Cast tecnico
Sceneggiatura: Rama Burshtein
Musiche: Yitzhak Azulay
Fotografia: Asaf Sudri
Montaggio: Sharon Elovic
Cast
Hila Feldman
Razia Israeli
Yohai Mendelman: Yiftach Klein
Esther Mendelman: Renana Raz
Yossi Mendelman: Ido Samuel
Chayim Sharir
Rivka Mendelman: Irit Sheleg
Shira Mendelman: Hadas Yaron
![]()
Sinossi: Lemale Et Ha’Chalal è la storia di una famiglia cassidica ortodossa di Tel Aviv. La figlia più giovane, la diciottenne Shira, sta per sposarsi con un coetaneo promettente che appartiene al suo stesso ambiente. È un sogno che si realizza e Shira è emozionata. Nel giorno di Purim, sua sorella Esther, appena ventenne, muore nel partorire il primo figlio. Il dolore che colpisce la famiglia causa il rinvio delle nozze di Shira. Tutto cambia quando viene proposto a Yochay, marito della defunta Esther, il matrimonio con una vedova belga. Yochay ritiene che sia ancora troppo presto, sebbene sappia che prima o poi dovrà riprendere moglie. La madre delle ragazze, temendo che il genero possa lasciare il paese portando con sé il suo unico nipotino, suggerisce il matrimonio tra Shira e Yochay. Shira dovrà scegliere tra il proprio sogno e il dovere verso la famiglia.
Commento della regista
L’amore e i rapporti tra gli individui costituiscono l’interesse principale del mio lavoro. L’arrivismo, l’indipendenza e la realizzazione di sé sono, per me, meno importanti dell’amore, di mio marito e della mia famiglia. Ciò che mi ha attratto della fede ebraica è il suo approccio all’enigma del rapporto tra uomo e donna. Questo processo mi ha letteralmente sbalordito. Lemale Et Ha’Chalal racconta una storia d’amore basata sullo spirito; ricorda l’esperienza e il sentimento del primo amore, che vive soltanto nel cuore e non ha alcun aggancio con la ragione. Il canto di un cuore verso un altro, insieme al desiderio volutamente represso è, per me, la formula vincente nella ricerca di una gioia duratura.

Shira è una diciottenne di Tel Aviv ed ha un promesso sposo scelto dalle rispettive famiglie. Perché, nella comunità Chassidim di Tel Aviv dove vive, trovare un marito è l’obiettivo più importante per una donna, fonte di un notevole impegno per tutti i nuclei familiari. Shira non conosce, però, come è usanza in quella comunità, il suo promesso, e sua madre, allora, glielo fa intravedere a distanza, in un supermercato della città. A Shira, a prima vista, il ragazzo piace ed è felice di quella designazione. Ma il destino ha in serbo per lei altri progetti. Durante la festività ebraica del Purim, infatti, improvvisamente, sua sorella Esther, incinta di ormai nove mesi, ha un malore, e muore pochi giorni dopo il parto. Il marito di Esther, Yochay, pertanto, rimane vedovo e con il loro figlio, appena nato, da accudire. La madre di Shira, distrutta ed assai provata dal dolore, pensa costantemente, ed in tutti i modi, a come riuscire a trovare una nuova soluzione esistenziale, per risolvere quella situazione così dolente. Escogita così l’idea di fare in modo che Shira sposi suo cognato, diventando, al tempo stesso, anche, la nuova madre del piccolo.

Gli ebrei ultra-ortodossi rappresentano un’enclave in cui l’intera esistenza delle persone che ne fanno parte, è in qualche modo, sottoposta a regole, in ogni momento, ed in ogni scelta, e nella quale la figura del rabbino capo, rappresenta un ineludibile riferimento per ogni membro. “Lemale Et Ha’Chalal” | “Fill the void” (in italiano “La sposa promessa“) – opera prima sottile ed intensa della regista Rama Burshtein, nata a New York, ma cresciuta, anche cinematograficamente, a Tel Aviv – pone questioni molto profonde sulla dialettica individuo-comunità. La vicenda di Shira e del cognato-marito Yochay, infatti, è, in qualche modo, la narrazione della nascita di un’attrazione, forse addirittura di un amore, ma al tempo stesso, dell’evoluzione e della maturazione di una ragazza giovane, che, con una complessa scelta, agita non senza coercizione, deve dire addio alla sua giovinezza, ed a tutti i suoi ineludibili miti. L’intelligenza della Burshtein consiste, a nostro avviso, nel mostrare le persone, in queste fasi molto delicate, attraverso il loro costante rapporto con le regole della società cui appartengono. Gli ebrei Chassidim costituiscono, sicuramente, anche nella narrazione filmica, una sorta di mondo a parte, rispetto a quello che noi consideriamo comunemente “emancipato”. Ma in questa consistente diversità, tutta contenuta ed agita in riti e consuetudini per noi apparentemente lontanissimi, riconosciamo, al tempo stesso, le nostre stesse emotività. Resta da capire, però, quanto, i nostri paradigmi interpretativi ci consentano ed abilitino, davvero, una loro adeguata, effettiva ed intima comprensione.

Il tentativo della regista è quello, però, di ridurre al minimo la dimensione, e la prospettiva religiosa del racconto, che pure, peraltro, costituiscono un imprinting forte della storia, e, direi, dello specifico filmico di Rama Burshtein, quella che – solo apparentemente – potrebbe palesarsi come la più decisiva. Il rabbino capo è il vero deus ex machina un po’ di tutte le relazioni della propria micro-società: elargisce consigli, soldi per andare avanti, ripara il forno ad un’anziana, e prende le sue decisioni ascoltando sempre le opinioni ed il parere di tutti i suoi membri. In questo modo,”Lemale Et Ha’Chalal” | “Fill the void“, ci riconduce con una progressione narrativa di notevole portata, all’origine della sfera religiosa: quella del mantenimento dell’ordine nella comunità. Ma quello degli Chassidim, minuziosamente costruito, non è un ordine unitario o irriguardoso, verso le scelte dei singoli. Shira viene, al contrario, ascoltata, le sue parole ed i suoi dubbi, sono presi sul serio, e le viene concessa, persino, la possibilità di una radicale riconsiderazione della scelta che sta per compiere. Lei, però, un po’ come tutti gli esistenti della storia, vive una liason, senza soluzione di continuità, con le aspettative e con i doveri dell’enclave comunitaria a cui appartiene. Ed alla fine, forse, s’innamora davvero di Yochay. Ma questa verità, noi, non la penetreremo mai fino in fondo, perché non sapremo mai, in definitiva, quanta parte – nelle decisioni individuali – subisca, effettivamente, la coercizione degli altri, e quanto sia, invece, il frutto del libero arbitrio, del pensare, e, quindi, dello scegliere autonomo di Shira.
 Il pregio di “Lemale Et Ha’Chalal” | “Fill the void” è quello di descrivere tutto un intero universo, apparentemente a noi estraneo, per molti aspetti addirittura ignoto (anche se, fuori dalle case ultra-ortodosse, non mancano i riferimenti al contemporaneo di Tel Aviv, la città più popolosa di Israele, con la sua modernità, la sua gioventù, le sue attenzioni alle tendenze, e, persino, alla moda), e fare, però, al tempo stesso, emergere, da quel distante micro-cosmo, un insieme di conflitti condivisi un po’ dovunque, nei quali darci modo d’identificarci. Difficile, però, riuscire a decidere quanto la pressione della madre, e della sua disapprovazione, incidano nel modellare, influenzare, costringere, lentamente, ma, progressivamente, il sentimento che Shira prova, effettivamente, per il cognato. Difficile riuscire a decifrare, anche, quanto, tutti i fidanzamenti a cui assistiamo durante il film, saranno poi, alla prova dei fatti, effettivamente, coronati da felicità ed appagamento. Difficile, infine, separare l’individuo dal tutto, in cui si muove ed agisce. Ciò non di meno, l’individuo non è, al tempo stesso, totalmente compresso dal contesto. Shira (interpretata dalla bravissima ed intensissima Hadas Yaron, premiata con la Coppa Volpi all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, davvero capace nel dare drammaticità ad un personaggio inquieto e tormentato, di difficilissima e complessissima esegesi interpretativa), è una ragazza di carattere, dice sempre, anche al costo di ferire sentimenti e sensibilità altrui, quello che pensa, e non è, in alcun modo, né condiscendente, né conciliante. Anche a Yoachay, peraltro, pare opportuno far di testa propria. Ma alla fine, entrambi, faranno quello che sembra effettivamente essere meglio per tutti. A ben guardare, direi proprio che uno dei pregi dello sviluppo del conflitto del racconto, è proprio questo delicato, continuo, e complesso equilibrio, tra questi due, opposti, estremi.
Il pregio di “Lemale Et Ha’Chalal” | “Fill the void” è quello di descrivere tutto un intero universo, apparentemente a noi estraneo, per molti aspetti addirittura ignoto (anche se, fuori dalle case ultra-ortodosse, non mancano i riferimenti al contemporaneo di Tel Aviv, la città più popolosa di Israele, con la sua modernità, la sua gioventù, le sue attenzioni alle tendenze, e, persino, alla moda), e fare, però, al tempo stesso, emergere, da quel distante micro-cosmo, un insieme di conflitti condivisi un po’ dovunque, nei quali darci modo d’identificarci. Difficile, però, riuscire a decidere quanto la pressione della madre, e della sua disapprovazione, incidano nel modellare, influenzare, costringere, lentamente, ma, progressivamente, il sentimento che Shira prova, effettivamente, per il cognato. Difficile riuscire a decifrare, anche, quanto, tutti i fidanzamenti a cui assistiamo durante il film, saranno poi, alla prova dei fatti, effettivamente, coronati da felicità ed appagamento. Difficile, infine, separare l’individuo dal tutto, in cui si muove ed agisce. Ciò non di meno, l’individuo non è, al tempo stesso, totalmente compresso dal contesto. Shira (interpretata dalla bravissima ed intensissima Hadas Yaron, premiata con la Coppa Volpi all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, davvero capace nel dare drammaticità ad un personaggio inquieto e tormentato, di difficilissima e complessissima esegesi interpretativa), è una ragazza di carattere, dice sempre, anche al costo di ferire sentimenti e sensibilità altrui, quello che pensa, e non è, in alcun modo, né condiscendente, né conciliante. Anche a Yoachay, peraltro, pare opportuno far di testa propria. Ma alla fine, entrambi, faranno quello che sembra effettivamente essere meglio per tutti. A ben guardare, direi proprio che uno dei pregi dello sviluppo del conflitto del racconto, è proprio questo delicato, continuo, e complesso equilibrio, tra questi due, opposti, estremi.

Il film è costruito con precisione, misura e controllo. Magari per una lunga parte dell’azione, soprattutto all’inizio, può apparire eccessivamente lento, ed anche un tantino inconcludente. Ma, al dunque, non è così. L’opera di Rama Burshtein si pone due obiettivi narrativi precisi: presentarci “quel” mondo ultra ortodosso, ed, in seguito, i comportamenti degli esistenti protagonisti, attraverso i loro caratteri. Il tentativo di Rama consiste, in pratica, nel filtrare la narrazione in un territorio neutro, cercando di eludere, totalmente, lo psicologismo e l’introspezione, mettendo, nella mise en scene, azioni semplici dalle quali – solamente – lo spettatore viene chiamato a dedurre intendimenti, logiche e pensieri. Persino nell’affrontare il tema della morte, evento dinamico da cui parte l’azione. Il dolore e la rimozione vengono vissuti all’interno dei dei linguaggi specifici di quel modo di vivere, e di costruire la società, ma la loro espressione più profonda (che sempre e solo nelle regole definite, può essere correttamente interpretata), non si lascia ingabbiare, nella sua totalità, dal conforto dei riti e delle preghiere. “Riempire il vuoto” (traduzione letterale del titolo originale), significa, perciò, molte più cose:
- riempire il vuoto della morte;
- quello della scelta;
- quello del cuore.
Le società sono, tutte in qualche misura, e quella narrata nel film in particolare, sempre pronte a farlo al posto tuo, pronte ad aiutarti, o, come in questo caso, a condizionarti. Ma proprio per queste ragioni, i Chassidim di Tel Aviv, non sono, alla fine, così tanto diversi da noi: la differenza è, tutto sommato, solo una questione di misura, non di sostanza.
Alla prossima.







 = Capolavoro
= Capolavoro = Eccellente
= Eccellente = Ottimo
= Ottimo  = Buono
= Buono  = Discreto
= Discreto  = Insufficiente
= Insufficiente = Mediocre
= Mediocre = Brutto
= Brutto = Punizione
= Punizione  = Incubo
= Incubo